
Il tardo Classicismo e l'Ellenismo. La lezione digitale
Verso la fine del V sec. a.C. la Grecia attraversa un periodo di drammatica crisi: è scossa prima dalle guerre tra le poleis per il predominio del Peloponneso e successivamente dalla conquista dei re macedoni. Si afferma un nuovo rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, mentre l’impegno civile si ridimensiona e i princìpi democratici si risolvono per lo più in forme di governo oligarchiche. A partire dal IV secolo a.C. la cultura e l’arte greche si espandono verso le regioni orientali grazie alle conquiste di Alessandro Magno. Nei tre secoli successivi si assiste all'ascesa delle città orientali (Alessandria d'Egitto, Pergamo, Antiochia, Rodi) come nuovi centri di promozione e diffusione della cultura greca, che assume così una dimensione internazionale.
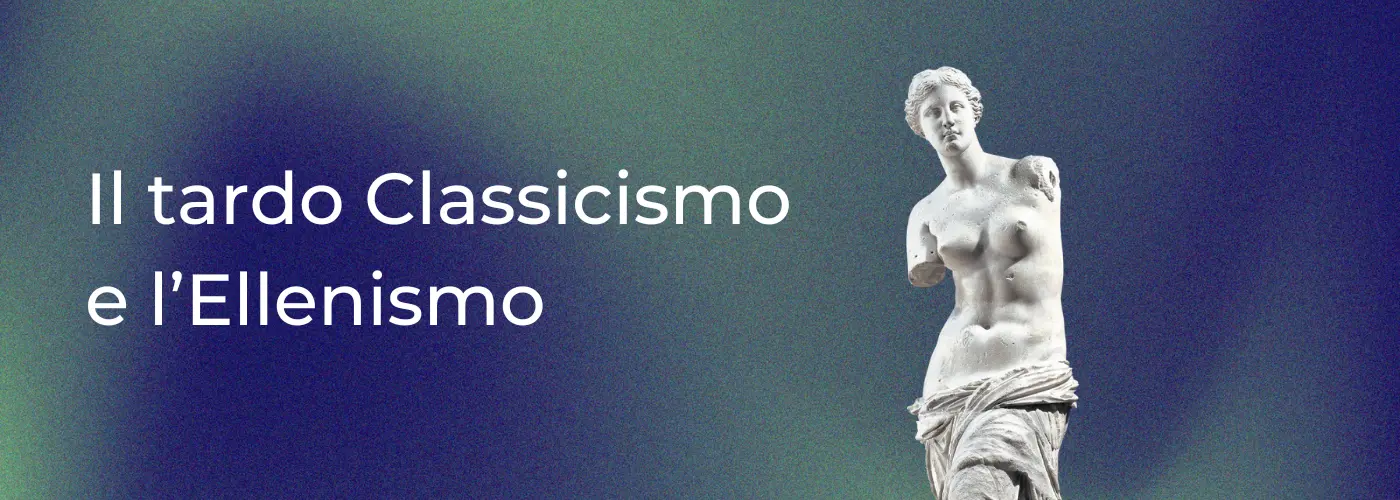
Chiarirsi le idee. L'arte nel tardo Classicismo
Alla fine del V secolo a.C. anche l’arte si fa interprete della rinnovata condizione storico-culturale. Le forme della scultura cambiano e aumenta l’indagine interiore dei personaggi: le divinità hanno un atteggiamento riflessivo e meno distaccato, gli atleti sono rappresentati in momenti intimi e non più durante le gare. Ne risulta un’accentuazione del pathos (sofferenza), soprattutto nelle espressioni del volto e nei gesti: nelle sculture, la dinamica del corpo assume maggiore naturalezza e si rapporta con lo spazio circostante. Il canone di Policleto è considerato un punto di partenza della ricerca espressiva e può essere rielaborato con libertà e inventiva. Si accentuarono in questo modo le differenze stilistiche tra artista e artista, anche perché la fine del policentrismo ateniese permise una formazione più diversificata.
Chiarirsi le idee. Tra spettacolarità e realismo
L’arte ellenistica interpreta e porta a compimento la crisi dei valori della società greca avviata nel IV secolo a.C.: i suoi interpreti si rifugiano sempre di più in una dimensione individualistica. Sia in architettura che in scultura gli artisti ricercano soluzioni dinamiche ed effetti spettacolari, strumenti di potere in mano ai monarchi assoluti. Luogo privilegiato di espressione è infatti la corte, dove si trova una committenza raffinata e facoltosa. Alla sensibilità classica per l’equilibrio e la bellezza, subentra un’esigenza di sfarzo fine a se stesso attraverso il virtuosismo tecnico. L’arte ellenistica diventa un’arte di rielaborazione: i modelli e il linguaggio dell’Arte classica vengono reinterpretati e declinati liberamente, manifestando l’esibizione di un forte realismo, espressione del senso drammatico dell’esistenza.
Dentro l'opera. Afrodite Cnìdia di Prassitele
La statua di Afrodite Cnidia di Prassitele fu originariamente collocata nel Santuario di Afrodite a Cnido. Lo scrittore Plinio afferma però che l’ammirazione per questa statua fu tale che l’opera originale venne spostata in un naòs aperto su più fronti, o forse in un tempietto circolare (monoptero), perché potesse essere osservata da più direzioni. Si tratta della prima volta in cui una dea appare nuda: Afrodite è ritratta mentre ripone la sua veste in un’anfora, per poi recarsi in bagno. Forte è il senso di umanità ritratto nel lieve movimento della dea.
Dentro l'opera. La Venere di Milo
Un passo in più. Laocoonte raccontato da Virgilio
Ci sono alcune opere destinate a rimanere per sempre nell’identità culturale e nell’immaginario di alcuni popoli. Oltre alla bellezza estetica, che rimane soggettiva, questo avviene quando l’arte riesce a rendersi immagine tangibile di una storia nota, che tutti hanno immaginato e di cui, in un certo senso, si sono sentiti parte, anche solo per discendenza storica. Questo accade, per esempio, con il Laocoonte, complesso gruppo marmorea realizzato a Rodi nella seconda metà del I secolo a.C. e attribuito a tre artisti operanti nella stessa bottega: Agesàndros e i figli Athenoròros e Polydòros.
L’episodio che vede protagonista Laocoonte è narrato nel ciclo epico della guerra di Troia, ripreso poi successivamente nell’Eneide dal poeta Virgilio.


